L’alba non facile dell’auto elettrica
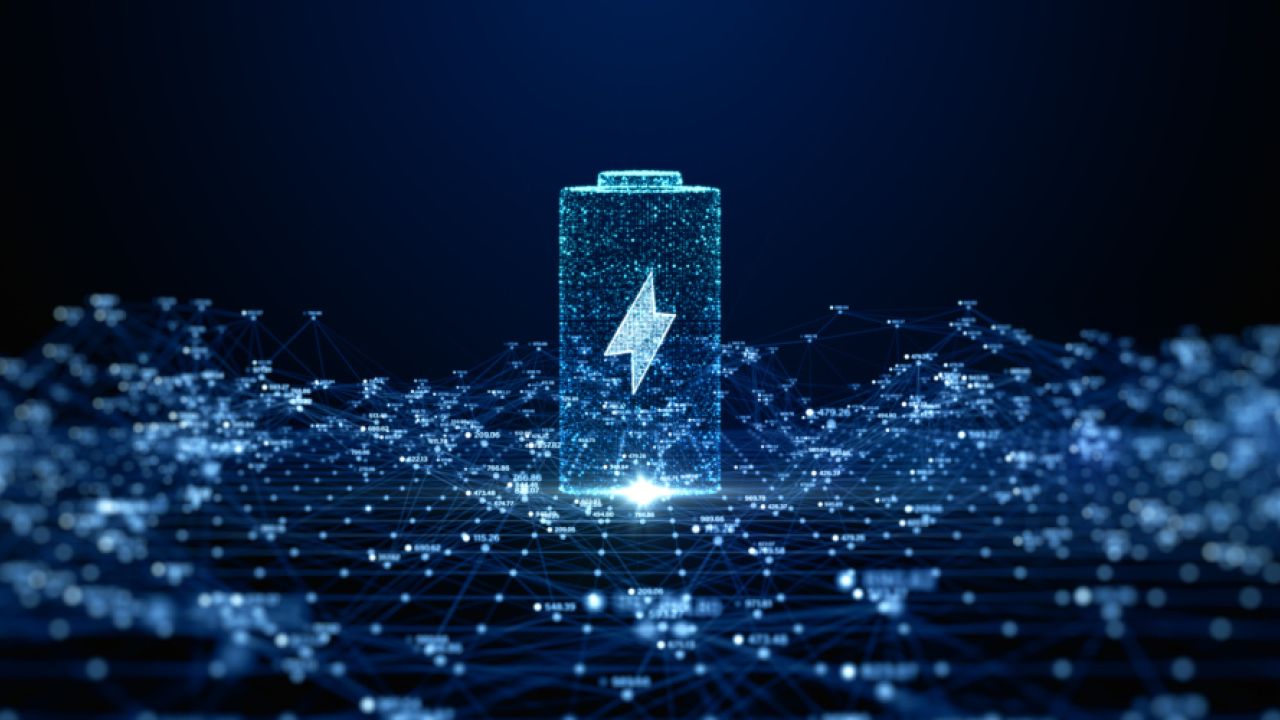
C’era un tempo in cui le auto elettriche erano viste come stranezze silenziose, poco più che giocattoli tecnologici per pionieri urbani o status symbol per ambientalisti benestanti. Oggi, invece, cominciano a occupare stabilmente corsie e parcheggi, silenziose e invisibili ma sempre più presenti. Il cambiamento è in corso, e riguarda tutti: consumatori, costruttori, governi. Eppure, l’elettrico non è ancora per tutti. Dietro ogni auto elettrica venduta si nascondono sfide e contraddizioni: prezzi ancora alti, autonomia che non convince tutti, infrastrutture di ricarica in ritardo, materie prime difficili da reperire. Allo stesso tempo, la tecnologia avanza, le batterie diventano più economiche, e gli incentivi statali spingono verso una nuova era. I costruttori tradizionali si reinventano, mentre nuovi attori, spesso cinesi, riscrivono le regole del gioco.
Intanto secondo i dati di Motus-E, le auto elettriche circolanti in Italia al 30 aprile 2025 sono 303.924, con le immatricolazioni full electric che da inizio anno sono pari a 29.668 unità, in aumento dell’82,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel solo mese di aprile le immatricolazioni delle auto elettriche sono pari a 6.646 unità contro le 3.159 dello stesso mese del 2024, con una differenza di 3.487 unità (110,38%). Superiore anche la quota di mercato mensile pari al 5,41%, rispetto al 3,24% registrato nel mese di aprile 2024.Il parco circolante BEV si attesta così a 303.924 unità. Intanto la Germania supera le 113.000 vetture elettriche immatricolate nel primo quadrimestre del 2025, sorpassando per la prima volta i veicoli diesel senza un sistema incentivante. Questo è sicuramente un dato storico.
Nel resto d’Europa, il quadro è più articolato. In alcune nazioni, come Norvegia e Paesi Bassi, l’elettrico ha ormai conquistato percentuali a due cifre nelle nuove immatricolazioni. In altri, come Germania e Francia, il trend è stato recentemente rallentato dalla fine degli incentivi o da una congiuntura economica meno favorevole. Tuttavia, il cammino sembra tracciato. Il Parlamento europeo ha confermato l’obiettivo di eliminare la vendita di auto nuove a combustione interna entro il 2035. La direzione è chiara, anche se la velocità varia.
L’Italia resta indietro, ma con visione, determinazione e politica industriale possiamo puntare a colmare il divario. Abbiamo superato la soglia delle 300mila auto elettriche pure circolanti, ma senza un piano organico, in particolare per le flotte e per i privati vulnerabili, sarà impossibile anche solo avvicinarsi agli obiettivi del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) al 2030. Nonostante segnali di ripresa il mercato BEV (Battery Electric Vehicle o più semplicemente Veicolo Elettrico a Batteria) in Italia è ancora contenuto.
Nello scorso mese di maggio il governo italiano ha deciso di deviare 597 milioni di euro destinati all’infrastruttura di ricarica per finanziare una nuova rottamazione selettiva delle auto e dei veicoli commerciali più inquinanti. L’obiettivo è sostituire circa 40mila veicoli a combustione con mezzi elettrici, in un tentativo di stimolare la mobilità a zero emissioni e recuperare parte del terreno perso nell’attuazione del PNRR. La misura, inclusa nella proposta di revisione tecnica del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), è stata recentemente approvata dalla cabina di regia.
I bonus non saranno per tutti indistintamente. Il nuovo schema di incentivi è pensato per essere più mirato e selettivo rispetto al passato. Il contributo sarà riservato a chi rottamerà un veicolo endotermico per acquistare un’auto elettrica nuova di categoria M1 (fino a 8 posti) oppure, per le microimprese, un mezzo commerciale elettrico delle categorie N1 e N2. Per le persone fisiche, il bonus sarà vincolato al reddito: 11.000 euro per chi ha un ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per chi rientra tra i 30.000 e i 40.000 euro. Le microimprese potranno ottenere un incentivo pari al 30% del valore del veicolo, fino a un massimo di 20.000 euro.
Impatto ambientale
La sostenibilità dell’auto elettrica è una questione complessa e va valutata lungo tutto il ciclo di vita del veicolo. In generale, l’auto elettrica è più sostenibile rispetto a quella con motore a combustione interna (benzina o diesel), ma non è a impatto zero. Le auto elettriche non emettono CO₂, NOx o PM10 durante l’uso, migliorando la qualità dell’aria urbana. Al contrario dei motori tradizionali che rilasciano gas nocivi. Questo è particolarmente rilevante nei centri urbani dove l’inquinamento da traffico è elevato. Oltre alla riduzione delle emissioni i BEV sono di conseguenza una soluzione per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
Le auto tradizionali a motore termico dipendono dalla benzina e dal gasolio, mentre l’auto elettrica è alimentata dall’energia elettrica, che può essere generata in modo più pulito da fonti rinnovabili come il sole, il vento o l’acqua.
La questione sostenibilità, però, non si esaurisce con la tecnologia. Cambiare il motore non basta a rivoluzionare il modello di mobilità. Una vera transizione richiede un ripensamento complessivo: meno auto, più trasporto pubblico, città più accessibili, incentivi alla mobilità attiva. In questo contesto, l’auto elettrica è una delle soluzioni, non la soluzione.
Sotto il cofano: le batterie
Al centro di questa rivoluzione silenziosa c’è una componente tecnica spesso poco visibile ma fondamentale: la batteria. È il cuore dell’auto elettrica, il serbatoio dell’energia che la alimenta. E’ bene ricordare che il costo della batteria pesa almeno del 25/30% sul costo complessivo dell’auto. Le batterie più diffuse sono quelle agli ioni di litio, che offrono un buon equilibrio tra densità energetica, durata e peso. Tuttavia, la loro produzione è tutt’altro che semplice o ecologica. Per estrarre il litio, ad esempio, occorrono grandi quantità d’acqua, spesso in zone aride del pianeta, come le saline dell’America Latina. Il cobalto, altro componente essenziale, proviene in buona parte dalla Repubblica Democratica del Congo, dove i metodi di estrazione sollevano preoccupazioni per l’ambiente e i diritti umani. Anche il nichel, utilizzato per aumentare la densità energetica, comporta impatti ambientali rilevanti.
Il costo ambientale della produzione di una singola batteria può essere elevato: alcune stime parlano di emissioni fino a 20 tonnellate di CO₂ per ogni batteria da 100 kWh, il che mette in discussione l’effettiva “pulizia” dell’auto elettrica se analizzata esclusivamente in fase di produzione. Ma è sul lungo periodo che l’elettrico inizia a riscattarsi. Durante l’uso, l’auto elettrica non produce emissioni dirette. Nessun ossido di azoto, nessuna particella fine, nessun rumore molesto. Se alimentata da fonti rinnovabili, può abbattere significativamente l’impatto ambientale rispetto a un’auto a combustione. Studi comparativi indicano che, dopo circa 60.000 km, un’auto elettrica compensa le emissioni legate alla sua produzione e inizia a risultare più sostenibile della controparte termica. In alcuni casi, il break-even point si raggiunge anche prima, se l’elettricità usata per la ricarica è generata da solare o eolico.
Naturalmente, tutto dipende dal contesto. In una rete elettrica ancora fortemente dipendente dal carbone o dal gas, i benefici ambientali dell’elettrico sono ridotti. In Europa, il mix energetico sta migliorando, ma la transizione non è uniforme. Alcuni paesi sono già a maggioranza rinnovabile, altri ancora faticano a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
La durata della batteria è un altro elemento cruciale. In media, una batteria agli ioni di litio mantiene una buona efficienza per almeno 8 anni o 150.000 km. Dopo questo periodo, la capacità di carica si riduce progressivamente, ma non si azzera. Molti veicoli continuano a circolare per anni con batterie parzialmente degradate, utilizzabili anche in ambito domestico come sistemi di accumulo energetico. Il tema del fine vita della batteria sta guadagnando sempre più attenzione. La sfida non è solo smaltirle in modo sicuro, ma anche recuperare i materiali preziosi in esse contenuti.
Il riciclo delle batterie è tecnicamente possibile, ma richiede impianti specializzati e normative adeguate. Alcuni paesi europei stanno già investendo in questa direzione, consapevoli che il futuro dell’elettrico passerà anche dalla capacità di chiudere il ciclo produttivo in modo circolare. In Europa lo smaltimento delle batterie in discarica è vietato: una volta terminato il primo ciclo di vita le batterie possono essere riutilizzate per altri scopi, in caso invece di usura completa è obbligatorio il riciclo dei materiali e dei componenti.
Negli ultimi anni l’Unione Europea ha avviato un programma ambizioso con l’obiettivo di alzare tra l’80 e il 90% entro il 2031 le percentuali di recupero mirato di materiali rari come il litio, cobalto, rame, piombo e nichel. Se realizzato consentirà di risparmiare sulla ricerca e sulla lavorazione interna delle materie prime, riducendo le attività minerarie: un’opportunità per i paesi europei per acquisire indipendenza industriale, crescita economica, produttiva e occupazionale, senza rinunciare al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale per cui l’elettrificazione della mobilità privata è già un tassello importante. Si stima che in Europa nel 2050 il riciclo delle batterie delle auto elettriche creerà un giro di affari da 6 miliardi di euro.
Autonomia e infrastrutture
Uno dei freni principali all’acquisto di un’auto elettrica è la cosiddetta ansia da autonomia, ma la realtà ci dice che queste auto coprono tra i 300 e 500 km con una carica. Il vero nodo resta la disponibilità di colonnine, soprattutto nelle aree extraurbane e nei piccoli comuni. La crescita dell’infrastruttura di ricarica rappresenta un elemento essenziale per la diffusione della mobilità elettrica e su questo fronte l’Italia si sta muovendo meglio di molti altri grandi Paesi europei.
In Italia, al 31 marzo 2025, risultano installati nella Penisola 65.992 punti di ricarica a uso pubblico. Per dare un’idea del ritmo della crescita, basti pensare che a marzo 2024 i punti installati erano 54.164 e l’anno precedente erano 41.173. Nei primi tre mesi del 2025 sono stati messi a terra 1.601 nuovi punti di ricarica.
Del totale, 50.931 punti di ricarica sono in AC con potenza inferiore a 50 kW, 10.831 sono di tipo fast DC con potenza tra 50 e 149 kW e 4.230 sono ultra-fast con potenza maggiore o uguale a 150 kW. I punti di ricarica ad alta potenza sono quelli che stanno registrando il tasso di crescita maggiore.
Vale sottolineare nell’ultimo periodo il deciso progresso delle installazioni nel Sud e nelle Isole, dove si concentra il 23% del totale dei punti di ricarica presenti della Penisola, a fronte del 20% del Centro e del 57 % del Nord Italia.
La Lombardia si conferma al 31 marzo 2025 la prima Regione per punti di ricarica (13.306 punti di ricarica), davanti a Lazio (7.040 punti), Piemonte (6.351 punti), Veneto (6.031 punti) ed Emilia-Romagna (5.225). Tra le Province, Roma è quella che al 31 marzo 2025 conta più punti di ricarica installati (5.605 punti), seguita da Milano (4.414 punti), Napoli (3.046 punti), Torino (2.903 punti) e Brescia (1.867 punti).
L’elettrico e la Pubblica Amministrazione
La mobilità elettrica rappresenta una sfida concreta e un’opportunità unica per ripensare la città, il territorio e il modo in cui ci muoviamo ogni giorno. Le amministrazioni locali possono fare la differenza, con i bandi PNRR, concessioni semplificate, collaborazione con operatori privati e scelte urbanistiche mirate. Non solo, possono promuovere filiere locali per il recupero e il riuso delle batterie, creare centri di raccolta specializzati e avviare campagne informative sulla sostenibilità dell’elettrico. Tutto questo deve valere sia per il trasporto pubblico e quello privato.
Il 2035, al momento, è la data simbolo: stop alle nuove auto a combustione interna. Ma la transizione non sarà automatica, occorrerà aggiornare i PUMS (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile), investire in ricerca e digitalizzazione, coordinare trasporti pubblici elettrici, car sharing e micro mobilità e infine, supportare imprese locali nella transizione della logistica. Le politiche pubbliche devono essere coerenti e lungimiranti. Incentivare l’acquisto di auto elettriche è importante, ma lo è anche investire in infrastrutture di ricarica, in reti energetiche intelligenti, in filiere produttive locali e sostenibili.
Le auto elettriche sono solo la punta dell’iceberg di una trasformazione più profonda che coinvolge il modo stesso in cui si concepiscono le città e gli spostamenti. La mobilità elettrica non è un destino inevitabile, ma una scelta che va guidata, con investimenti, norme chiare e politiche pubbliche intelligenti. Non si tratta solo di cambiare veicoli, ma di ripensare il rapporto tra città, cittadini e mobilità.
Glossario
Veicoli BEV Battery Electric Vehicle ovvero un veicolo elettrico a batteria
Veicoli PHEV sta per “Plug-in Hybrid Electric Vehicle“, ovvero veicolo elettrico ibrido plug-in.
Sono i veicoli ibridi plug-in, combinano motori elettrici e a combustione interna. La presenza di due motori rende queste auto più pesanti e meno efficienti rispetto a quelle BEV, senza trascurare la manutenzione più frequente a causa della doppia alimentazione. Inoltre, anche se ridotte, le emissioni sono presenti
Range Extender Vehicle (E-REV): un veicolo elettrico a batteria che include un piccolo motore ausiliario a combustione col solo scopo di ricaricare la batteria. A differenza del Plug-in Hybrid, il Range Extender non è in grado di far funzionare il veicolo meccanicamente.
Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV): anche il FCEV si affida unicamente a un motore elettrico, ma diversamente dal BEV, l’elettricità è generata da celle a combustibile idrogeno invece che da batterie. Le celle a combustibile idrogeno generano elettricità combinando l’idrogeno con l’ossigeno. Come il BEV, il FCEV è 100% privo di emissioni a livello locale.
Batteria agli ioni di litio (Li-ion): Tipo di batteria ricaricabile comunemente utilizzata nei veicoli elettrici per la sua alta densità energetica e durata.
Capacità della batteria (kWh): Quantità di energia che la batteria può immagazzinare. Più kWh = maggiore autonomia.
State of Charge (SoC): Percentuale di carica presente nella batteria in un determinato momento.
State of Health (SoH): Indicatore della salute della batteria rispetto allo stato originale (nuova).
Ciclo di carica/scarica: Un ciclo completo dalla carica piena alla scarica e ritorno. Le batterie hanno una durata stimata in cicli.
Deep Discharge: Scarica profonda della batteria, può ridurne la durata se frequente.
Regenerative Braking (frenata rigenerativa): Sistema che recupera energia in frenata e la reimmette nella batteria.
Battery Management System (BMS): Sistema elettronico che gestisce la batteria per ottimizzarne prestazioni, sicurezza e durata.
Thermal Management System: Sistema di gestione della temperatura della batteria (raffreddamento/riscaldamento).
EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment): Attrezzatura per la ricarica, comunemente nota come colonnina o wallbox.
Tipo 1 / Tipo 2 / CCS / CHAdeMO: Standard di connettori per la ricarica AC/DC (es. Tipo 2 in Europa, CCS per ricarica rapida).
AC (corrente alternata): Tipo di ricarica più lenta, tipicamente domestica.
DC (corrente continua): Ricarica rapida presso colonnine ad alta potenza.
Kilowatt (kW): Unità che misura la potenza di ricarica (es. 7 kW = ricarica domestica veloce; 150 kW = ricarica ultra-rapida).
Fast Charging / Rapid Charging: Ricarica veloce (AC o DC), riduce i tempi rispetto alla ricarica domestica.
Range Anxiety: Ansia da autonomia, timore di restare senza carica durante il viaggio.
Motore elettrico (EM): Convertitore di energia elettrica in movimento, molto più efficiente di un motore a combustione.
Inverter: Dispositivo che converte la corrente continua (DC) della batteria in corrente alternata (AC) per alimentare il motore.
Trasmissione diretta: Molti EV usano trasmissioni semplici o dirette (senza cambi), grazie alla flessibilità del motore elettrico.
Torque istantaneo: Caratteristica del motore elettrico di fornire coppia massima immediatamente.
Piattaforma skateboard: Architettura con batteria piatta sotto al pianale, motore elettrico integrato agli assi.
WLTP sta per “Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure” ed è una procedura di prova standardizzata a livello globale per la misurazione dei consumi e delle emissioni di gas di scarico dei veicoli.
EPA (Environmental Protection Agency) è l’agenzia statunitense per la protezione ambientale che definisce standard più rigidi per le auto elettriche
NEDC: ciclo di prova che veniva utilizzato per misurare il consumo di carburante e le emissioni dei veicoli in Europa prima dell’introduzione del ciclo WLTP
Autonomia (Range): Distanza che un’auto elettrica può percorrere con una carica completa.
Efficienza (kWh/100km o km/kWh): Misura di quanto energia consuma il veicolo per percorrere una distanza.
ISO 26262: Standard per la sicurezza funzionale nei sistemi automobilistici.
Protezione IP: Grado di protezione contro polvere e acqua (es. IP67).
Crash Safety (protezione batteria): Sistemi di protezione meccanica ed elettronica per prevenire danni alla batteria in caso di urto.
Second life battery: Riuso delle batterie EV per altri scopi (es. accumulo stazionario) quando non sono più adatte all’uso su strada.
Recycling: Processo di recupero di materiali preziosi (litio, cobalto, nichel) dalle batterie a fine vita.














